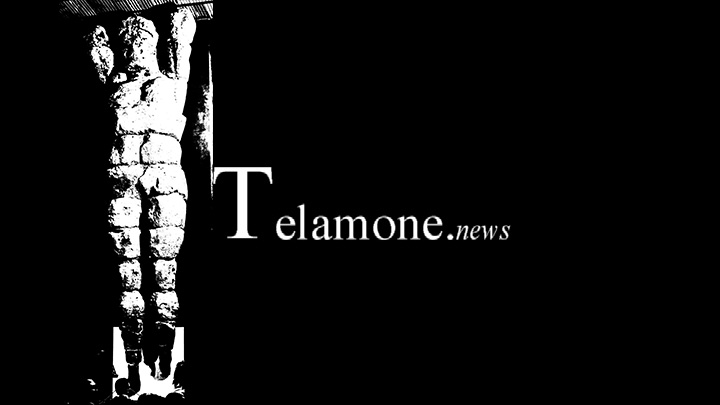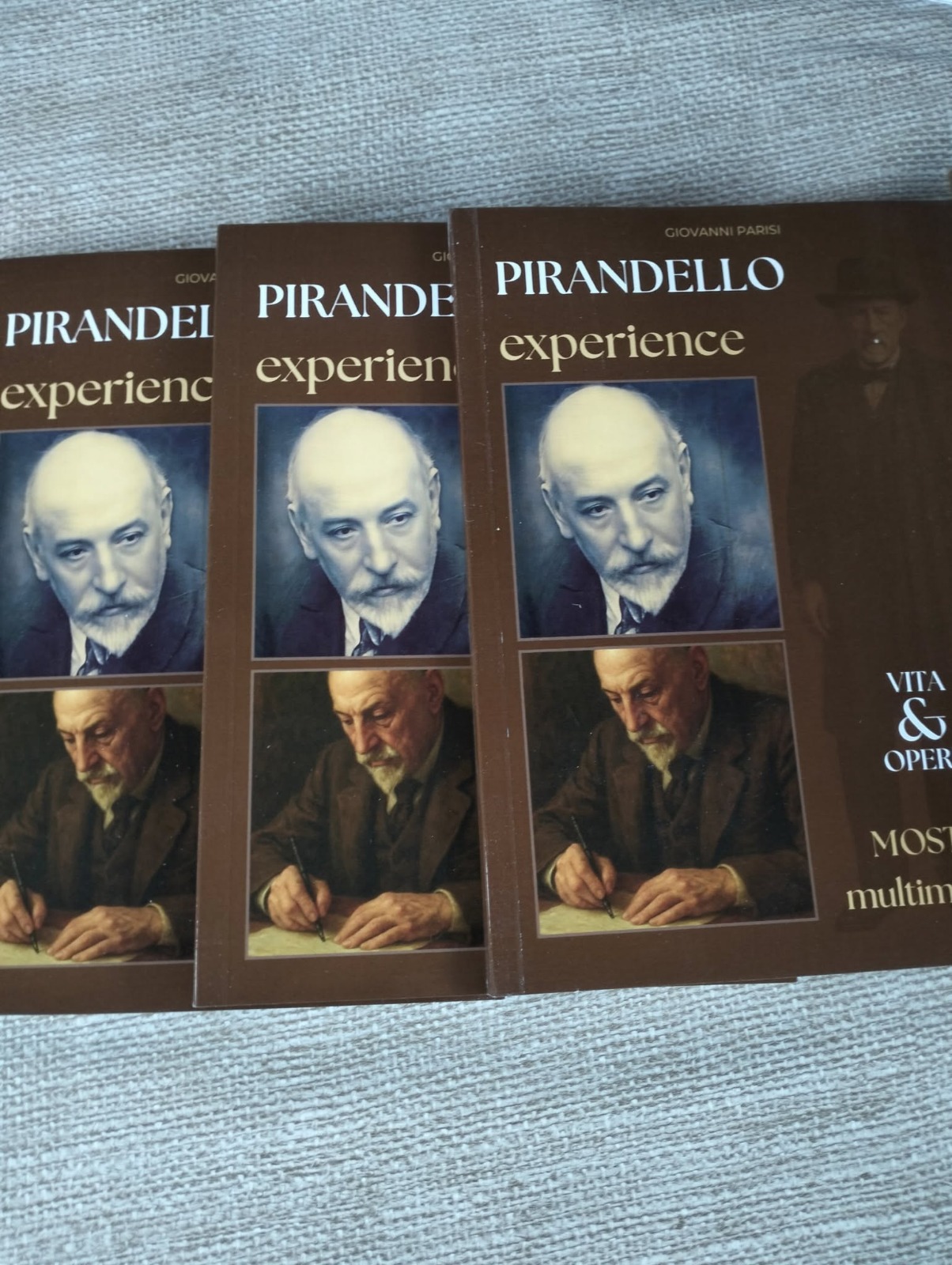di Giovanni Parisi
Una mattina di fine estate del 2010 credo , in Via Atenea, come al solito incontrai il professor Enzo Lauretta, che alle 11 in punto come tutti i giorni prendeva la solita pausa caffè. Con quella sua aria distinta e affettuosa, mi salutò e mi invitò a prendere il caffè nel bar accanto la Farmacia Nastri
Mi offrì un caffè – gesto semplice, ma carico di una familiarità antica – e, con tono confidenziale, mi invitò l’indomani nel suo ufficio al Centro Studi Pirandelliani. “Ho da parlarti di una cosa che mi frulla in testa da anni,” disse, e già negli occhi gli brillava un’idea.
Di idee, il professore ne aveva avute a decine — anzi, a centinaia — ma non starò qui a elencarle tutte. Mi limiterò a citarne alcune tra le più emblematiche e durature: il Festival Internazionale del Folklore, che contribuì a dare respiro internazionale ad Agrigento; il Convegno Pirandelliano, autentico punto di riferimento per studiosi e appassionati dell’opera del nostro premio Nobel; e naturalmente il prestigioso Premio Efebo d’Oro, che univa con rara intelligenza il linguaggio del cinema a quello della narrativa, in una sintesi di alto profilo culturale.
Il professore lo conobbi personalmente nel 1970, quando già dirigeva con entusiasmo e rigore il gruppo folkloristico “Val d’Akragas”, da lui fondato diversi anni prima. Fu quello il primo contatto con il suo mondo: un mondo fatto di passione, metodo, ambizione culturale e, soprattutto, visione. In seguito, ebbi il privilegio di collaborare con lui per numerose edizioni del Convegno Pirandelliano, oltre che per molte altre sue iniziative, sempre animate da un’inesauribile energia creativa e da un profondo rispetto per la tradizione e l’identità del nostro territorio.
Nel corso degli anni, Enzo Lauretta è stato per me molto più di un semplice intellettuale di riferimento: è stato un autentico maestro di vita e di professionalità, un uomo capace di trasmettere – con l’esempio più che con le parole – il valore dell’impegno, della cultura, della coerenza, e del servizio alla propria comunità. In ogni progetto, anche il più ambizioso, sapeva vedere oltre l’immediato: coglieva il senso profondo del fare cultura in una terra difficile, ma capace di grandi slanci. E per questo, ancora oggi, gli sono profondamente grato.
Al Palacongressi dove si svolgeva il convegno pirandelliano era sempre il primo ad arrivare anche mezz’ora prima dell’orario stabilito
Il mattino seguente, come un personaggio chiamato alla sua parte, mi presentai puntuale. La puntualità, per lui, era una forma di rispetto quasi sacra, più che abitudine. Mi accolse con la consueta cordialità e, senza troppi preamboli, mi parlò del suo progetto: ripristinare la Festa del Signore della Nave, proprio come narrata nella celebre novella di Pirandello.
«Una festa che ad Agrigento apparteneva al popolo e alla tradizione, al mare. Dobbiamo farla rivivere,» disse, e già vedevo in lui non più il professore, ma il regista di un dramma antico, pronto a ridare voce ai personaggi della novella dimenticati:
il Mastro-Medico: Un vecchio medico di campagna, arguto e disincantato, che offre osservazioni caustiche sulla natura umana. Il sig. La Vaccara con le Figure legate alla preparazione del banchetto.
I Marinai miracolati: Un vecchio e un giovane marinaio che si trovano alla sagra per ringraziare il Signore della Nave. Una Donnaccia e una Meretrice: il Veterinario, Macellaio, NorcinoI venditori ambulanti.
E tanti vari altri personaggi: Sposi, ragazzi, venditori, la moglie del signor Lavaccara e le sue figlie.
La festa, da celebrarsi come da tradizione nel mese di settembre, avrebbe avuto due momenti distinti: uno religioso – con la processione del Crocifisso nella chiesa di San Nicola e uno laico, di nostra competenza. Dovevamo organizzare un convegno con relatori, alcuni interventi artistici e a conclusione, una degustazione ispirata al menù narrato da Pirandello: fritto di pesce, maiale, le classiche anisette con i semi di finocchio e altri sapori antichi.
Naturalmente, tutto il peso dell’organizzazione ricadeva sul Centro Studi, che non godeva – e qui la voce del professore si fece quasi ironica – di alcun sostegno da parte delle istituzioni. «È chiaro,» mi disse con un sorriso sornione, «che la tua collaborazione dovrà essere gratuita, salvo piccole spese che ti chiedo di anticipare… per l’aspetto tecnico e per la degustazione.»
Accettai. Come si può dire di no a un’illusione che, pur sapendo di essere illusione, pretende di diventare realtà?
Mi misi all’opera senza indugi. Il tempo era poco, le cose da fare tante. Curai personalmente la comunicazione sui media locali – televisione, giornali, tutto quel che allora era possibile. E arrivò il primo sabato di settembre.
Nel pomeriggio, nella sala del museo, il convegno si svolse con grande partecipazione. I relatori erano di spessore, il pubblico attento, curioso, grato. Si respirava un senso di riscatto culturale, un tentativo, forse ingenuo e nostalgico di restituire un pezzo di anima alla città attraverso l’opera del grande scrittore Agrigentino.
Alla fine, quando il sole cominciò a calare e il cielo si tingeva di arancio, nel piazzale antistante il museo si svolse la degustazione. I piatti erano ispirati alla novella di Pirandello: pesce fritto, carne di maiale, pane caldo, anisette il tutto accompagnato da bicchieri di vino rosso, semplice ma sincero, come una volta.
La gente rideva, chiacchierava, assaggiava con curiosità e piacere. Alcuni anziani si fermavano in silenzio, con gli occhi lucidi, e raccontavano come fosse la festa tanti anni prima. Erano commossi: rivederla prendere vita dopo tanto tempo li faceva sentire di nuovo parte di qualcosa di importante.
In quell’atmosfera speciale, sembrava quasi che i personaggi di Pirandello si fossero confusi tra la folla. Camminavano accanto a noi, in silenzio, con un mezzo sorriso. E per un momento, realtà e fantasia si toccavano.
La domenica seguente, la processione del Crocifisso richiamò centinaia di persone. Fu una festa sincera, sentita, che unì sacro e profano nel modo in cui solo certe tradizioni riescono a fare.
Il professore, pur avendo speso di tasca propria una somma ragguardevole, era felice. Felice in quel modo strano, trattenuto, ironico, che appartiene a chi ha più visto andar via le cose che vederle arrivare. E, com’era nel suo stile, già dava appuntamento all’anno seguente: «Faremo di più, vedrai.» mi disse quando andammo stanchi ma felici a casa.
L’anno dopo, ci mettemmo al lavoro già ai primi di agosto. Gli proposi di coinvolgere lo chef Salvo Prestia, docente dell’alberghiero di Favara, e il catering fu affidato a Salvatore Collura, titolare del ristorante “Leon D’Oro” oggi, purtroppo, chiuso. Come tocco finale – la famosa ciliegina – contattai un caro amico, regista Rai, Peppe Sciacca, che all’epoca dirigeva Uno Mattina su Rai Uno per una partecipazione alla trasmissione.
Ebbene, andammo in diretta: quindici minuti di trasmissione nazionale, in cui il professore, lo chef Prestia ed io raccontammo l’iniziativa, ognuno con le proprie competenze ovviamente il suo valore, il legame profondo con la terra e la cultura e Pirandello. Un successo d’immagine straordinario per Agrigento, tutto – ancora una volta – a costo zero per le istituzioni preposte.
Settembre arrivò e con esso un’altra edizione della festa, ancora più ricca, con servizi su Mediaset, Rai, stampa locale. Ma, com’era prevedibile, né il Comune, né la Provincia, né la Regione – né le aziende del turismo – ritennero opportuno sostenere economicamente un progetto così partecipato.
«Gli obiettivi delle amministrazioni,» diceva il professore con una smorfia ironica, «sono sempre altrove.»
Oggi, di quella festa resta solo il ricordo. Un ricordo vivo, sì, ma come certi sogni che si fanno al mattino: intensi, dettagliati, eppure destinati a svanire con la luce del giorno.
Non ci fu una terza edizione. I costi, gli impegni, l’indifferenza delle istituzioni—tutto si mise contro. Eppure, chi c’era sa che, per un breve tempo, ad Agrigento si era riaccesa una scintilla. Una scintilla di bellezza autentica, fatta di cultura, di memoria, di condivisione. Di quelle che non urlano, non promettono, non pretendono… ma lasciano il segno.
Il professor Lauretta, con la sua visione generosa e la sua ostinazione gentile, come sempre, ci ha insegnato che fare cultura è un atto d’amore. E come ogni atto d’amore vero, spesso non viene capito. Ma resta. Resta nei volti della gente, nelle parole che ancora oggi si scambiano ricordando quei giorni, in una fotografia ingiallita, in una risata tra il fritto e il vino, in un angolo di piazza che profuma ancora di vita.
Forse, in fondo, è proprio questo il senso più profondo della festa: non il suo ripetersi, ma il suo essere accaduta. Una volta, intensamente. Come certe cose preziose, che non tornano più, ma non se ne vanno davvero.
Rimane il ricordo. Di un’intuizione. Di una fatica. Di una città che, per un attimo, sembrò credere di nuovo a se stessa.